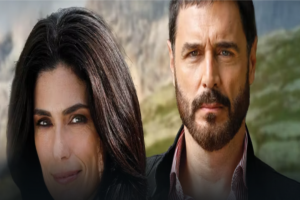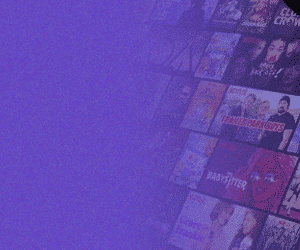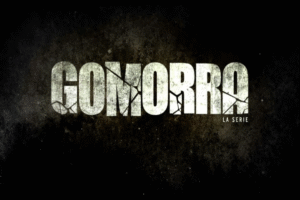Il film Parthenope di Paolo Sorrentino ha catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto per la sua complessa rappresentazione di Napoli e per la simbologia legata alla disabilità. Uno degli elementi più discussi è la figura del figlio del professor Marotta, interpretato da Alessandro Paniccia. La rivelazione di questo personaggio, che appare solo verso il finale, ha suscitato emozioni intense e riflessioni sul significato della sua rappresentazione. Attenzione: l’articolo contiene spoiler.
Indice dei contenuti
Chi è il figlio del professor Marotta
Il personaggio del figlio del professor Marotta è avvolto in un alone di mistero per buona parte del film, fino a quando viene rivelato nella scena culminante. Interpretato da Alessandro Paniccia, il personaggio è descritto come un macrocefalo obeso, che sembra “un bambino nel corpo di un gigante”. Questa condizione appare simbolica della fragilità e della complessità di Napoli stessa, tema ricorrente nei film di Sorrentino.
Il professor Marotta, interpretato da Silvio Orlando, inizialmente evita di presentare il figlio alla protagonista, Parthenope, suggerendo un istinto protettivo, o forse una paura del giudizio. Tuttavia, con il progredire della narrazione, si comprende che la scelta di Marotta nasce dal desiderio di far incontrare Parthenope e suo figlio solo quando lei sia pronta per comprenderne il significato simbolico.
“È fatto di acqua e sale”
La scena in cui il figlio di Marotta guarda in televisione un programma condotto da Angelo Manna rappresenta uno dei momenti più profondi e toccanti del film. Il ragazzo ride con spontaneità a una battuta volgare, mostrando una reazione che, pur semplice, è carica di significato. In questo momento, Marotta pronuncia la frase: “È fatto di acqua e sale”, a cui Parthenope risponde con “Come il mare… come me”. Questa frase, in apparenza semplice, rimanda alla città di Napoli, spesso raffigurata come un luogo di bellezza e vulnerabilità, simile a un figlio fragile che necessita di protezione.
L’acqua e il sale evocano il mare, elemento vitale per Napoli, e riflettono la complessità emotiva e fisica della città. Con questa frase, Sorrentino sembra voler sottolineare il legame indissolubile tra Napoli e i suoi abitanti, rappresentati simbolicamente dal figlio di Marotta, che diventa una figura emblematica della città stessa, con tutte le sue contraddizioni.
Il significato nascosto della scena
Paolo Sorrentino è noto per la sua propensione a lasciare margine d’interpretazione allo spettatore, e in Parthenope questo si manifesta nella rappresentazione del figlio di Marotta. Il regista evita spiegazioni razionali, spingendo invece il pubblico a riflettere autonomamente. In questa scelta c’è anche una denuncia sociale implicita: nel passato, le persone con disabilità erano spesso tenute ai margini della società, una realtà che Sorrentino porta alla luce attraverso la decisione di Marotta di custodire il figlio lontano dagli occhi del mondo.
L’intellettuale Marotta incarna l’amore e la sofferenza di chi si dedica alla cura di Napoli, una città che, per bellezza e problematiche, è spesso difficile da comprendere e gestire. Marotta simboleggia la figura di chi è chiamato ad amare e a prendersi cura di questa città complessa, nonostante le sue contraddizioni.
La città di Napoli e il figlio di Marotta
Il figlio del professor Marotta rappresenta la città di Napoli nel suo essere al contempo meravigliosa e fragile. Il film suggerisce che Napoli, proprio come il figlio di Marotta, richiede pazienza, comprensione e protezione. Le difficoltà del ragazzo simboleggiano i problemi che affliggono Napoli, e il gesto di amore e protezione del professor Marotta diventa metafora di un legame profondo e irrinunciabile con la città. Parthenope, nella sua crescita e maturazione, comprende che l’amore per Napoli è fatto di accettazione e di cura verso i suoi lati più delicati e difficili.
La creazione del personaggio
Un elemento affascinante del film è la trasformazione fisica di Alessandro Paniccia nel ruolo del figlio di Marotta. L’attore ha condiviso sui social alcune immagini che mostrano il processo di trucco e preparazione necessario per rappresentare il personaggio. Il lavoro svolto dietro le quinte evidenzia l’impegno profuso per dare vita a una figura così intensa e simbolica. La trasformazione dell’attore, che diventa un “bambino gigante” dalle fattezze singolari, sottolinea l’intensità emotiva di questo personaggio, portando in scena il lato più toccante dell’estetica cinematografica di Sorrentino.